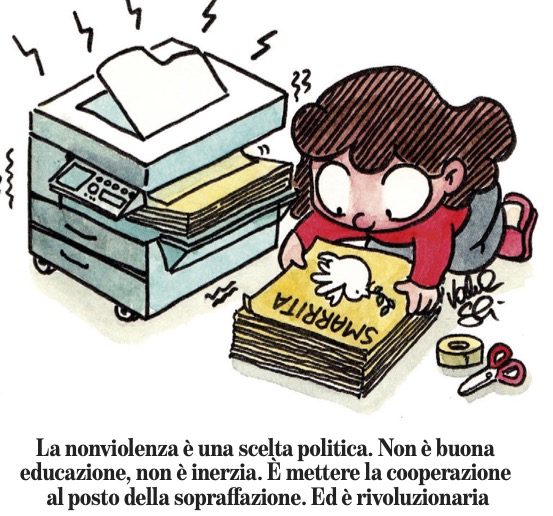La destra al governo ha stanziato 32 miliardi per la spesa militare, di cui 13 solo per i sistemi d’arma, stabilendo un nuovo, inutile, record. Intanto viene tagliata la spesa sociale. La denuncia di Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete italiana pace e disarmo in una intervista per il numero di gennaio 2025 di LEFT
L’ultima legge di bilancio del governo Meloni ha stanziato 32 miliardi per la spesa militare. Francesco Vignarca, ora siamo davanti a un balzo?
C’è una forte accelerazione specie per i sistemi d’arma. Un aumento considerevole, che però non è avvenuto di colpo. Negli ultimi dieci anni abbiamo registrato una crescita del 60 per cento della spesa militare. Negli ultimi 5 anni, solo per armamenti, è salita al 70 per cento e oltre.
Ricordiamo che nel 2022 anche il ministro Guerini (Pd) propose 13 miliardi in più di spese militari.
Sì, l’incremento delle spese militari in Italia era già una tendenza in atto da tempo. Già nel 2014 la Nato cominciò a parlare di questo famigerato traguardo del due per cento del Pil in armamenti, un discorso poi supportato da molte retoriche. Negli ultimi tre o quattro anni, a causa della guerra in Ucraina le spese per armamenti sono aumentate di molto. Anche perché è più facile agire su questo capitolo. Far crescere la spesa militare aumentando gli effettivi, le basi militari, la gestione operativa, non è realizzabile rapidamente. Non è facile, di colpo, assumere diecimila soldati in più. È molto più semplice aumentare la spesa acquistando più carri armati, più aerei: basta firmare contratti. Detto in sintesi: quando si è insediato il governo Meloni fondamentalmente ha mantenuto la spesa che ha ereditato dal governo Draghi. Successivamente ha cominciato a incrementarla per i sistemi d’arma fino al record storico di quasi 13 miliardi.
È a rischio la legge 185 del 1990 che vieta l’export di armi verso Paesi che violano i diritti umani e/o che sono in guerra?
Nel 2024 il governo Meloni ha portato avanti un disegno di legge per modificare quella legge e depotenziarla, per esempio eliminando la parte sulla relazione che presenta i dati sulle banche. Del resto Crosetto, in veste di ministro della Difesa e prima, ha detto a chiare lettere che le banche che vogliono essere etiche non entrando nel commercio di armi rappresentano un problema. Addirittura ad un certo punto è arrivato a paventare la nascita di una banca solo per l’export di armi. Da qui la scelta consequenziale del governo di modificare la legge 185, peggiorandola. Fra il 2023 e il 2024 questa modifica è stata approvata alla Camera. Quando fummo auditi segnalammo le criticità. Poi quel processo di modifica si è un po’ arenato perché il governo ha avuto altre priorità, altre emergenze, anche in quello stesso ambito. Per esempio ha dovuto modificare la legge sulle missioni militari all’estero. Per ora, dunque, è tutto sospeso riguardo alla 185. Per il futuro però è stata ribadita l’intenzione del governo di diminuire la trasparenza sull’export di armi.
Che rapporto c’è fra l’export di armi e la spesa militare?
C’è un rapporto stretto. Quando vengono dati sussidi all’industria militare per pro- durre di più (magari con la scusa che serve all’esercito italiano) si genera sovrapproduzione che poi viene piazzata all’estero. Il problema è che con le esportazioni, come abbiamo già visto negli anni passati, le armi vanno a finire in zone del mondo piene di conflitti e che continuano a crescere. Accadrebbe ancora di più in futuro se ci fosse quella diminuzione della trasparenza di cui parlavamo prima.
Quella militare è un’industria trainante in Italia?
Assolutamente no. È un’industria residuale per l’economia del Paese. Ecco il fatto paradossale. È un’industria piccola dal punto di vista dei numeri come dimostrano le ricerche di Greenpeace e di Sbilanciamoci e come dimostrano addirittura i dati di Mediobanca recentemente diffusi. Parliamo di una industria che non arriva all’1 per cento del Pil ed è molto piccola anche dal punto di vista dell’export. La percentuale sale un po’ se guardiamo a ricerca e sviluppo, ma questo settore non ha ricadute su obiettivi civili. Tuttavia la propaganda ha fatto breccia. Quando tengo una conferenza chiedo sempre a chi mi ascolta quanto pesa sull’economia la spesa militare. Perlopiù rispondono l’8, il 10, il 12. Nessuno dice che l’industria militare vale meno dell’1 per cento del Pil.
Cosa copre questa propaganda pro armamenti?
Favori. Si arriva a sacrificare pezzi interi del bilancio dello Stato per acquistare armi. Lo si fa in nome di interessi futuri ma che non hanno ritorno. Mentre lo Stato ha altre urgenze. La Corte costituzionale ha detto che la spesa sanitaria deve essere privilegiata rispetto a tutto il resto. Non ci sono motivi di bilancio, né patti di stabilità europei che tengano rispetto a questa priorità perché serve a garantire il diritto alla salute e la vita delle persone. Per giunta, ribadisco, garantire le spese militari non porta nemme- no un vantaggio economico. Ed è una faccenda che non riguarda solo l’Italia. Tanti governi stanno andando sempre di più verso l’aumento di spese militari facendo scelte insensate. Per questo come Rete italiana pace e disarmo stiamo lavorando a campagne internazionali. La società civile pacifista deve concentrasi sempre più su un punto cruciale: la battaglia per ridurre le spese militari si lega a quella per la sanità e l’ambiente. Serve una campagna trasversale.
Guardando alla sfera globale notiamo che la spesa militare è raddoppiata negli ultimi 25 anni. Con l’aggressione della Russia all’Ucraina c’è stata un’escalation. Ora anche la Francia è in economia di guerra e la presidente della Commissione europea Von der Leyen spinge in quella direzione. Come leggere tutto questo?
C’è una palese manipolazione dei dati di realtà. L’Ucraina e la Russia sono in economia di guerra. Ma loro sono davvero in guerra. Le spese per la difesa per loro sono prioritarie, purtroppo. E vediamo la devastazione che deriva da questo conflitto soprattutto in Ucraina. Altri Paesi europei che non sono in guerra hanno deciso scientemente di cercare di risolvere la presenza di questi conflitti aumentando la spesa e una presenza militare; cosa che per altro si è rivelata fallace oltreché problematica. Dunque usare questa retorica della spesa militare necessaria per la difesa come fa Ursula von der Leyen è sicuramente affermare qualcosa di falso.
Cui prodest?
Risponde agli interessi di chi produce armi e del comparto militare finanziario che controlla tante cose ed anche la politica. Questa è la verità. Ma l’escalation nel riarmo ci viene fatta passare come un fatto necessario. Il problema è il continuo martellamento per imporre questa falsa necessità, pericolosa e inutile. Anche a livello globale si riscontra la stessa tendenza che in Italia, ma il raddoppio della spesa militare dal 2001 non ha portato più pace. Più soldi spendiamo per le armi più crescono le guerre, i morti civili, l’insicurezza; è sotto gli occhi di tutti. Per questo hanno dovuto creare questa retorica dell’economia di guerra. In Francia le connessioni fra gli interessi armati e la politica sono, se possibile, ancora maggiori che in Italia. C’è un collegamento diretto molto forte fra produzione di armi ed economia. A cui si aggiunge il tema del nucleare. I funzionari della difesa assomigliano ormai a commessi viaggiatori del marketing delle armi. Oltralpe questa tendenza è palese già da un paio di anni. Quel che mi preoccupa di più è che sia diventato centrale anche per l’Europa.
Nell’Unione europea il tema della difesa ha preso il posto di quello della salute?
È così, purtroppo. Dopo lo scoppio della pandemia abbiamo impiegato due anni per iniziare a ipotizzare un debito comune per uscirne in modo positivo ed avere più protezione sanitaria. Ma ecco che questa conquista viene cancellata. Politico ha sollevato un caso: i fondi strutturali per la coesione non spesi (che tra l’altro erano assegnati all’Italia per il Sud) potrebbero essere stornati dalla Commissione alla spesa per armamenti.
C’è un problema che riguarda anche la ricerca applicata che serve all’industria delle armi?
Bisogna fare attenzione ai criteri su cui si basa questo tipo di ricerca. Non è accettabile che le industrie che producono armi disumane, messe al bando dai trattati internazionali, vengano considerate sostenibili solo perché l’industria vuole così. Non gli basta fare migliori affari, vogliono cambiare lo scenario.
Quanto al progetto di una difesa comune?
Questa corsa al riarmo sta minando lo stesso percorso di creazione di una politica estera comune di difesa dell’Europa. Se per un attimo mi tolgo il cappello di attivista e provo a immedesimarmi in chi vuole un’Europa forte non posso che constatare che il sostegno all’industria e le spese fanno fare sempre più affari al comparto militare finanziario, non stanno garantendo una crescita militare dell’Europa. Se si vuole davvero una difesa comune, un esercito comune, una presenza più forte dell’Europa non si deve partire dall’industria e dai soldi per le armi ma al contrario è necessario fare un percorso politico per costruire un intento comune fra Paesi. Se quando c’è da decidere un intervento siamo ancora divisi e frammentati in 27 posizioni diverse, la scelta del riarmo non serve a niente, se non a ingrassare il fatturato delle aziende militari.
Abbiamo parlato molto di economia, vorrei approfondire di più la questione politica e culturale, per noi centrali. In Italia abbiamo uno strumento rivoluzionario: l’articolo 11 della Carta. Ma viene troppo spesso disatteso nonostante sia evidente che i momenti più alti e creativi della nostra storia sono stati quelli in cui abbiamo ripudiato la guerra..
Non saremmo quello che siamo se non ci fossero stati percorsi di pace. Ci raccontano la storia umana come una storia di guerre, ma le guerre ci hanno fatto arretrare, ci hanno riportato indietro. L’articolo 11 della nostra Carta è cruciale ma deve essere declinato politicamente e culturalmente. I padri e le madri costituenti non hanno scelto il verbo rifiutare, non hanno scritto non ci interessa la guerra, hanno scelto il verbo ripudiare che indica un atto forte, che ha una rilevanza di azione. È come dire “mi rendo conto che la guerra fa schifo, porta distruzione e la rifiuto” ma per allontanarla devo fare una scelta concreta, pragmatica. Forse in 80 anni di Repubblica non abbiamo capito che ripudiare la guerra vuol dire costruire percorsi alternativi, rafforzare le diplomazie, i momenti di pace. Le forze armate servono costituzionalmente per una eventuale difesa ultima, ma in realtà vengono usate anche per tutt’altro. Con Strade sicure, fin dal 2008, in risposta a una questione sociale sono state inviate le forze ar- mate per le strade. Ma cosa c’entra? Non siamo mica una Repubblica sudamericana degli anni Settanta.
E che dire dei pacifisti dell’ultim’ora come Salvini?
Salvini fa finta di essere pacifista solo per mantenere i suoi interessi politici ed economici con certi Paesi come abbiamo visto bene qua in Nord Italia. Si dice pacifista ma perché non si deve andare contro il suo amichetto Putin. Il pacifismo è altro!
Come possiamo definire il pacifismo?
È rifiuto della guerra come strumento, rifiuto della sua preparazione, è necessità di sottolineare altre scelte che favoriscono il processo di pace a cominciare dalla necessità di corpi civili di pace, della diplomazia. Potrebbe anche essere un modo per far riaffezionare alla politica la nostra società civile che tutto sommato, nonostante il martellamento mediatico, è contro le armi, contro le spese militari. L’ultimo rapporto del Censis riporta che solo il 30 per cento degli italiani vuole che si raggiunga il 2 per cento delle spese militari. Ed è tanto più significativo perché in questi anni non si sono visti i pacifisti in tv e sui media mainstream. Dobbiamo trovare un modo oggi per far capire a tutti che la pace non è una scelta imbelle, di comodo, di rimessa, di inattività ma è una scelta molto attiva, molto diretta ed è l’unica che funziona. Lo dimostrano anche le esperienze di Emergency di Un ponte per e di tante altre Ong che operano quotidianamente con questa idea. Se noi facciamo vedere che il pacifismo è una pratica attiva, sensata e seria potremmo fare pressione come massa critica e la politica non la potrà più ignorare.
La nonviolenza è anche un strumento che rivoluziona il modo di pensare i rapporti sociali, perché rifiuta la logica vita mea mors tua. È un modo per creare una società diversa insieme agli altri?
La nonviolenza è lo strumento che ci permette di rafforzare la scelta di pace, perché è una scelta politica. È il Satyāgraha gandhiano, è la forza della verità. Se cooperiamo creiamo valore, questa consapevolezza è una rivoluzione copernicana. Aldo Capitini la chiamava il «varco attuale della storia»: io sto meglio se coopero, io sono più sicuro se non mi metto ad attaccare gli altri ma costruisco la società. E questo lo abbiamo già in parte visto realizzato. Se ci pensiamo bene secoli fa non si poteva uscire la sera, andare a fare quattro chicchere in un luogo pubblico o uscire per andare ad ascoltare una conferenza, tutti avremmo avuto paura. Oggi noi ci sentiamo sicuri tanto da non andare in giro armati, non accadeva così in passato. Nel momento in cui abbiamo deciso di non armarci singolarmente ma di essere tutti disarmati e cooperativi con una costruzione di fiducia siamo arrivati alle società di oggi in cui siamo al sicuro come non mai. In Italia si registrano 300 omicidi all’anno, nel 1990 erano ben oltre mille. Beninteso 300 sono ancora troppi, ma dobbiamo riconoscere che il tasso di violenza in generale è diminuito. Certo, se si continua ad alimentare la diffidenza come certi politici stanno facendo, c’è il rischio di fare passi indietro.
La nonviolenza dunque è una scelta politica?
È scegliere la cooperazione al posto della competizione. La nonviolenza non è buona educazione, non è bon ton, non è la buona maniera. La nonviolenza ha una declinazione politica ed è questa la grande intuizione di Gandhi che non ne faceva una scelta solo personale e filosofica. E noi dobbiamo andare avanti su questa strada rispetto ai conflitti di oggi. Per questo abbiamo portato in Italia gli obiettori, i Refusenik israeliani e palestinesi nonviolenti che lavorano insieme. Riconosciamo e condanniamo l’oppressione dell’occupante (lo Stato di Israele) ma sappiamo che solo dalla cooperazione fra le popolazioni che sono ostaggi dei loro governanti potremo costruire un futuro diver- so, più giusto e di pace. Altrimenti il rischio e avere nuovi Afghanistan, Iraq, Siria. Se togli un oppressore sanguinario, te ne arriva un altro. Se non cambi la mentalità politica il rischio è quello.